
26 Mar Genitori permissivi
Come un forte vento che spira, a volte verso una direzione, altre volte nella direzione opposta, piegando al suo passaggio tutto ci? che incontra, come un fuoco che rapidamente dilaga sui monti, nel permissivismo come nellautoritarismo sono coinvolti non solo singoli individui o piccoli gruppi sociali, ma spesso, questi atteggiamenti tendono ad interessare vari strati sociali o addirittura intere popolazioni, comprese le strutture politiche, amministrative e religiose.
Il motivo di ci? ? difficile da comprendere se non si accetta il fatto che lessere umano ? coinvolto, per sua natura, da atteggiamenti e comportamenti contrapposti che in qualche modo rompono o sono divaricanti rispetto ad un recente passato, sottovalutando, dimenticando o cancellando insegnamenti ed esperienze pi? lontane.
In una societ? che assume unimpronta permissiva, le regole e le leggi gradualmente assumono contorni e soprattutto applicazioni particolari con ampliamento a dismisura della sfera delle libert? individuali.
In tale contesto i regolamenti e le leggi diventano sempre pi? comprensivi dei bisogni e delle necessit? dei singoli, a scapito dei bisogni collettivi, quali quelli della famiglia, dei figli, della societ?.
In altre societ? come in quella italiana, pur essendo vigenti leggi molto severe, queste sono interpretate con molta comprensione e molta liberalit?. La loro applicazione non avviene o avviene solo saltuariamente come nei casi pi? gravi ed eclatanti, mentre in quelli che non danno scandalo o immediata preoccupazione sociale, le norme vengono raggirate o molto edulcorate.
Ci? spesso avviene o si diffonde gradualmente in tutti i settori e livelli amministrativi, ma anche nella sfera religiosa e morale: dalla famiglia, alla scuola; dallesercito alle chiese, dal parlamento alla giustizia. Per tale motivo gli atteggiamenti dei superiori o dei responsabili assumono caratteri di eccessiva comprensione, tolleranza, flessibilit?, indulgenza, condiscendenza.
Chiudere un occhio o entrambi diventa la norma. Capire chi sbaglia, chi pecca, chi commette un crimine o un’inosservanza della legge o dei regolamenti, diventa bont?, magnanimit?, virt?. Certi particolari sono rivelatori di questo clima di benevolenza e di condiscendenza eccessiva.
Ad esempio nelle nostre scuole superiori e da qualche tempo anche nelle scuole medie, ? invalso luso della vacanza sciopero o della vacanza occupazione. Cio? delle vacanze sostenute da motivazioni molto spesso cos? labili e pretestuose che i giovani stessi che attuano quello che ? chiamato impropriamente sciopero od occupazione non le conoscono o non ci credono affatto; eppure in giorni canonici come il sabato, in quelli che permettono di fare lunghi ponti o nei giorni in cui ? pi? conveniente riposarsi dopo altre precedenti vacanze, lo sciopero ? l? pronto per essere utilizzato allungando i giorni di vacanza, per permettere di effettuare la settimana corta o semplicemente per impedire il pericolo di interrogazioni o lascolto di noiose lezioni. In queste occasioni molti docenti e autorit? scolastiche assumono degli atteggiamenti a dir poco ambigui, per non dire di piena complicit? creando dei presupposti diseducativi di cui solo pochi avvertono la valenza. Per tali motivi:
a) il numero dei giorni di scuola e quindi di formazione si riduce notevolmente con grave danno alla cultura e alla formazione di intere generazioni.
b) si alimenta nei giovani il sentimento di onnipotenza: Siamo noi che decidiamo quando fare o non fare il nostro dovere;
c) si educa alla fuga dalle responsabilit?, dal sacrificio e dagli impegni;
d) si introduce tra educatori ed educandi una complicit? perversa che riguarda gli impegni e i doveri reciproci: Io ti permetto di non fare lezione, tu mi permetti di fare vacanza, con conseguente perdita di autorevolezza e stima nei confronti degli educatori e degli adulti in genere.
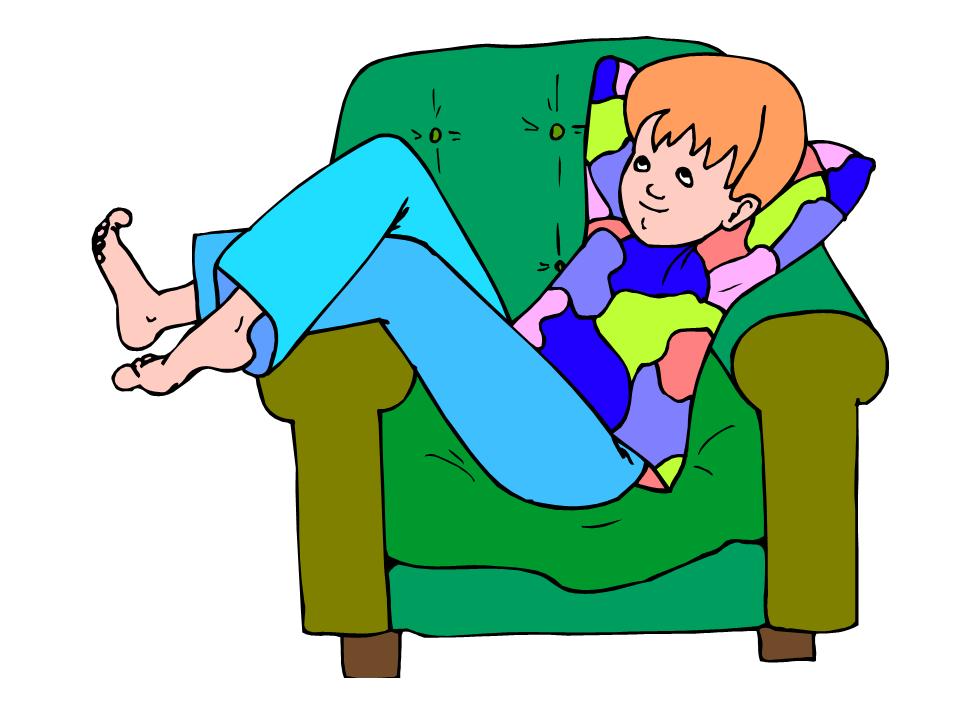
Un altro tra i numerosissimi esempi che potremmo fare si ritrova nelle nostre chiese. Fino a qualche decennio fa i confessionali erano pieni di penitenti, ma le comunioni erano scarse rispetto ai frequentatori della S. Messa in quanto laccostarsi alla comunione comportava la consapevolezza del peccato e limportanza della sua purificazione mediante la confessione e la promessa di non commetterlo pi?. Attualmente avviene il contrario: i confessionali sono vuoti, ma le persone che si sentono in grazia di Dio e quindi fanno la comunione sono moltissime.
Ci chiediamo: Ci si sentiva forse troppo indegni e peccatori allora, per cui ci si accostava alla comunione con gran timore e responsabilit? sui propri comportamenti, oppure ci si sente pi? puri, pi? santi, o comunque si avverte la divinit? pi? disponibile al perdono e allaccoglienza, oggi?
In altri casi invece, come nella societ? americana attuale, le leggi e la repressione hanno un andamento schizofrenico, in nome della libert? individuale vengono accettati comportamenti personali e collettivi ad alto rischio o chiaramente lesivi della personalit? dei minori, nel contempo i reati pi? gravi vengono severamente puniti.
Come dire:Tu fin da piccolo puoi essere sottoposto a migliaia di stimoli alla violenza, alla sopraffazione, allodio, e alla distruzione da parte della TV, dei giornali, dei videogiochi, dei film. Fin da piccolo puoi subire i traumi pi? pesanti e disturbanti nati dalla libert? degli educatori: separazioni, divorzi, allontanamento da uno o entrambi i genitori, aggressivit? familiare, carenze affettive ed educative, piccoli e grandi traumi da parte dei coetanei, degli adulti che girano per casa, nuovi fidanzati di pap? e mamma, nuovi amanti, giochi dadulti.
Chiudo un occhio e non oso punirti se dici le parolacce, se sei aggressivo o strafottente con i genitori e con i professori e gli altri adulti. Non minteressa se nel tuo cuore attecchiscono al posto dei valori dellamore, della tolleranza, dellaffetto, della disponibilit? i disvalori diffusi nella nostra societ?: potere, denaro, sesso, arroganza.
Sono comprensivo e pronto a capirti se fai uso dalcool o di droga. Puoi benissimo comprare tutte le armi che vuoi e diventare sempre pi? bravo nel colpire una sagoma umana al cuore, o nel frequentare delle palestre che tinsegnano a colpire e colpire forte lavversario, ma, se uccidi in uno scatto dira una persona antipatica o aggressiva con la pistola nuova che pap? e mamma ti hanno regalato per Natale, diventi un criminale degno della pena capitale.
E un disegno e un percorso ideologico perverso, che inserisce pene severissime per atti gravi, mentre ? permissivo per le piccole mancanze che per? sono il presupposto e preparano quelle gravi. Soprattutto questo tipo datteggiamento, falsamente liberale, non riesce a creare un clima educativo e formativo, solido, serio, stabile, con una visione ampia e profonda della realt? interiore del bambino e del giovane.
La logica perversa si fonda sullassunto, errato, che ? la volont? dellessere umano che guida in definitiva ogni sua azione, mentre le influenze ambientali hanno scarso valore. Sappiamo, per contro, che ci? ? vero solo parzialmente, poich? la volont? ? spesso piegata nel bene e nel male dai vissuti interiori fatti di valori, norme, esperienze, paure, ansie, depressione ecc..
CARATTERISTICHE DEI GENITORI PERMISSIVI
Viziano i figli.
Non si fanno rispettare da loro.
Fanno spesso appello alla coscienza, al giudizio e alla capacit? di scelta dei figli.
Credono eccessivamente nelle capacit? educative dellesperienza.
Giustificano ampiamente se stessi e sono molto tolleranti nei riguardi dei comportamenti dei figli.
Dicono rari e timidi no.
Fanno molte minacce ma raramente le attuano.
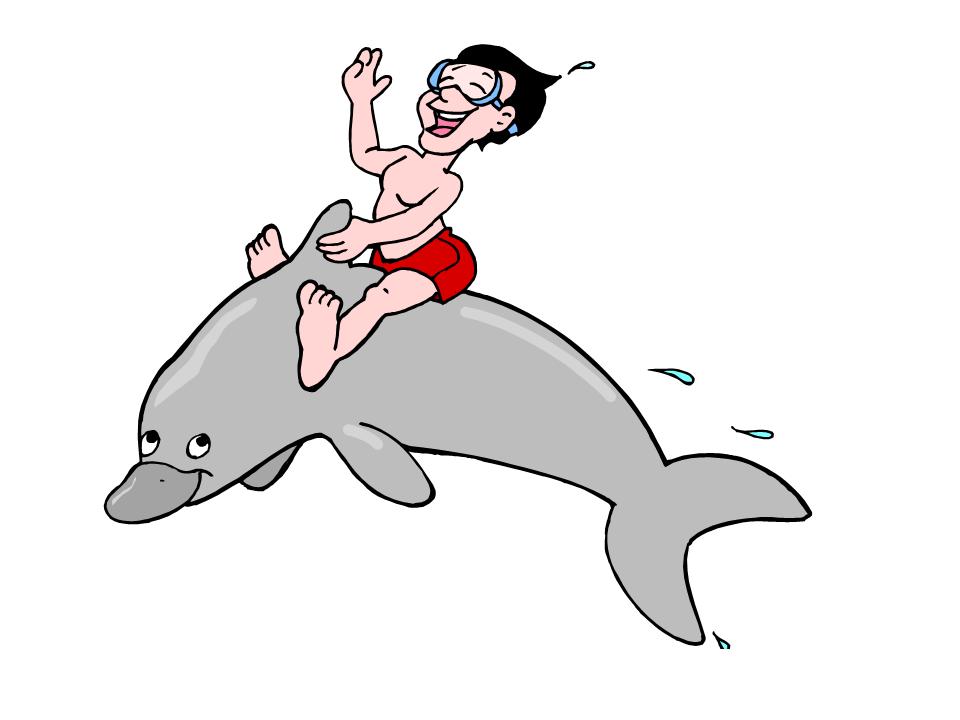
Viziano i figli.
Viziare un figlio significa essere eccessivamente indulgenti di fronte alle sue richieste, concedendogli su richiesta o, altre volte, anticipando i suoi desideri, molto di pi? di quanto non gli serva in quel momento per la sua crescita, evitandogli ogni difficolt? e ogni sacrificio.
In altri casi non ? solo un problema di quantit?, ma anche di qualit?, giacch? al figlio sono concesse delle cose e delle esperienze che non gli sono per nulla utili perch? premature o fuorvianti, o lesive della sua personalit?, ma, poich? sono da lui cercate e desiderate, o comunque poich? sono comuni e di moda, diventa quasi un obbligo offrirle.
Si possono fare molti esempi: ai bambini piacciono e sono molto utili i giocattoli, ma regalar loro continuamente o eccessivamente significa farli utilizzare male, giacch? essi non hanno il tempo di scoprire tutte le loro potenzialit?. Soprattutto significa spegnere in loro il piacere del desiderio, del sogno, dellattesa, dellevento tanto pi? bello quanto pi? raro e agognato.
Ai giovani piace stare tra loro in gruppo; ma ci? ? utile solo ad a condizione che sia un gruppo formato da persone sane, che il tempo trascorso nel gruppo non sia eccessivo e sia alternato da un tempo almeno altrettanto lungo trascorso con gli adulti: poich? per? ? usanza che i giovani stiano sempre insieme, ci si adegua senza tenere conto degli aspetti limitanti e pericolosi di tale pratica.

Non si fanno rispettare dai figli.
Il rispetto nasce da molti elementi, dalle qualit? della persona, dalle sue virt?, maturit?, autorevolezza; ma nasce anche dal ruolo e dal modo di porsi nei confronti dei figli: se ci si pone come amici, con caratteristiche vicine allet? delleducando per il piacere di sentirsi giovane tra i giovani o per una visione distorta del ruolo genitoriale, il rispetto dei figli diventa minimo o scompare del tutto. Per cui i genitori saranno trattati e maltrattati come se fossero dei coetanei scocciatori e seccatori.
Fanno spesso appello alla coscienza, al giudizio, alla capacit? di scelta dei figli.
Che i genitori gradualmente e tenendo in giusto conto e valore let? dei figli, la loro capacit? di gestione, la loro maturit?, lambiente con cui vengono in contatto, facciano appello alla loro coscienza, al loro giudizio e capacit? di scelta ? non solo un bene, ma elemento essenziale nelleducazione. I genitori autoritari che tendono a svalutare molto tutti questi elementi nel figlio, assumendoli in prima persona, impediscono o soffocano queste potenzialit?.
Purtroppo i genitori permissivi cadono nellerrore opposto: supponendo nel figlio capacit? di giudizio, di coscienza, e duso della volont? superiori a quelli realmente possedute, per cui pretendono da loro delle responsabilit? eccessive che non sono in grado di gestire adeguatamente; anche in questo caso ? un problema di criterio ed equilibrio, piuttosto che di scelte radicali tra libert? individuale e controllo da parte delle figure educanti.
Credono eccessivamente nelle capacit? educative dellesperienza.
I genitori permissivi credono eccessivamente nelle capacit? educative dellesperienza. E vero che lesperienza ? maestra di vita e che da esperienze errate si possono trarre molti utili insegnamenti, ma ? anche vero che ogni realt? deteriore lascia nellanimo umano una traccia indelebile che pu? spingere e sostenere verso traguardi pi? alti e degni delluomo, come pure pu? umiliare, condizionare e schiacciare la parte pi? nobile e produttiva dellanimo, condizionando in senso negativo tutta la vita di un giovane.
Giustificano ampiamente se stessi e sono molto tolleranti nei riguardi dei comportamenti dei figli.
Tra genitori e figli ? giusto che ci sia solidariet?, complicit?, sostegno reciproco, ma contemporaneamente ? bene che, fin da piccoli, i figli sappiano assumersi le proprie responsabilit? nelle scelte che operano, sia nel bene sia nel male. Dare agli altri: insegnanti, amici, societ?, stato, televisione, torti che possono essere in tutto o in parte frutto di scelte individuali, significa deresponsabilizzarsi e deresponsabilizzare chiudendosi in un mondo ovattato che preclude o sminuisce ogni responsabilit? personale.
Anche la tolleranza, che significa rispettare le idee altrui, quando ? eccessiva pu? contribuire a sottovalutare o a negare principi e valori, per tale motivo pu? portare a situazioni di rischio morale, psicologico, fisico o sociale.
Dicono rari e timidi no.
I no dei genitori permissivi sono rari, ma soprattutto non sono coerenti con i successivi comportamenti. Spesse volte questi no si trasformano in un s? o in un n?: in pratica si trasformano in unaccettazione passiva e non convinta della volont? del figlio. Quando, poi, questi genitori riescono a mantenersi fermi nella loro posizione iniziale, ne soffrono tanto e si sentono talmente in colpa, che quasi chiedono scusa e perdono al figlio per il comportamento avuto e cercano di rimediare concedendo cose che prima non si sarebbero sognati di concedere.
Fanno molte minacce ma raramente le attuano.
I genitori permissivi, spesso, in preda allesasperazione gridano, urlano, litigano, rimproverano, minacciano di punizioni severissime, ma poi difficilmente attuano quanto minacciato.
Altre volte puniscono ma, successivamente, accettano che il figlio faccia quello che essi precedentemente avevano negato.
Per farsi ubbidire e per fare in modo che i figli si comportino adeguatamente puntano soprattutto sulla relazione affettiva e sul senso di colpa. Per tale motivo si aspettano un comportamento adeguato e ubbidiente come scambio damore e di riconoscenza e non perch? sia giusto e corretto quanto da loro richiesto. Ritorna presto se non mi vuoi far soffrire, preoccupare, restare in pena, dice la madre al figlio che non intende tornare a casa in un’ora canonica.
A volte i genitori permissivi vedendo nelle malefatte e nella disubbidienza dei figli tratti di un carattere forte, vivace e aggressivo ne sono lieti, per cui il loro rimprovero nasconde un intimo orgoglio e soddisfazione che vengono immediatamente percepiti dai minori.
Il genitore permissivo si accosta a volte ai comportamenti dei figli con grande ansia e trepidazione. Spesso non sa il modo corretto per affrontarli, ogni suo comportamento gli fa nascere mille dubbi, mille perplessit?, che i libri e i suggerimenti di psicologia e pedagogia spesso non aiutano a fugare. Rimprovera, grida, impreca per poi pentirsi. Proibisce per poi concedere. Cerca il consiglio o laiuto daltri adulti pi? autorevoli ma poi non riesce a seguire le loro indicazioni o si oppone e sconfessa le loro azioni in quanto le avverte come troppo dure e crudeli nei confronti del figlio. Altre volte preferisce vivere in una beata incoscienza. La supervisione sui figli diminuisce e diventa altalenante: in alcuni giorni ? massima, in altri si perde completamente. Egli si affida, allora, in maniera completa, alle capacit? di critica e di scelta di questi o confida sul caso o sulla provvidenza divina. In ogni caso finisce per abdicare al proprio ruolo deducatore e cessa dessere modello didentificazione, pertanto non riesce pi? a portare avanti quei valori essenziali per lindividuo e per il corretto vivere civile.
Quando il genitore permissivo si accorge che i suoi comportamenti hanno provocato la rovina fisica o/e morale del figlio reagisce in modo istintivo e spesso aggressivo nei confronti del figlio stesso. Le madri coraggio spesso sono madri che per molti anni non hanno per nulla dimostrato coraggio nei loro mille comportamenti quotidiani; quando denunciano e mandano in galera i figli che le aggrediscono, le picchiano o le derubano per procurarsi la droga, reagiscono con un estremo e totale gesto di rifiuto e daggressivit? alle mille angherie che hanno subito senza riuscire a reagire efficacemente e razionalmente.

CAUSE DEL COMPORTAMENTO PERMISSIVO
1. La mancanza di un capo famiglia.
La presenza di due autorit? al posto di una permette pi? facilmente ai figli di giocare sul conflitto che si crea in queste situazioni per ottenere quanto desiderato, anche perch? ? noto che la presenza di due persone al vertice di unistituzione, grande o piccola che sia, comporta spesso una grave carenza di direttive e norme uniformi e coerenti. Sappiamo infatti che spesso due autorit? = nessuna autorit?.
2. Presenza del genitore unico.
Quando i due genitori si presentano con ruoli diversi e complementari da entrambi accettati e valorizzati, come in un gioco di squadra ognuno svolger? il proprio compito sapendo di potere contare su quello del compagno: la madre che ha un ruolo pi? tenero e permissivo si appogger? allautorit? paterna e viceversa. In questo caso il risultato sar? ottimale in quanto bilanciato. Quando invece i due genitori si presentano con un ruolo unico ? facile che questo venga ad essere sbilanciato in un senso o nellaltro.
3. I motivi ideologici.
Nel comportamento permissivo entrano in gioco, altre volte, motivi ideologici: si porta alle estreme conseguenze il concetto di libert? e dautocoscienza, per questo si confida e ci si affida eccessivamente alla capacit? del minore di effettuare libere scelte senza pensare che la coscienza e la volont? umana maturano gradualmente con gli anni, perci? solo nelladulto si ha quella maturit? e pienezza cognitiva, capace di poter dare la giusta valutazione ai fatti e alle azioni, comportandosi di conseguenza. N? si tiene nel giusto conto che anche nellet? adulta sono indispensabili norme, divieti e sanzioni, che stimolino la volont? ad attivarsi verso delle scelte positive e utili per lindividuo e per la comunit? tanto che ogni societ? ne elenca nelle sue leggi e regolamenti una quantit? impressionante.
4. Il rifiuto dellautorit? e della autorevolezza.
Come abbiamo detto parlando dellautorevolezza se questa viene vista come violenta, antiliberale e non moderna, e pertanto viene rifiutata e bollata di autoritarismo, i genitori e gli educatori vengono spinti volenti o nolenti verso atteggiamenti permissivi pi? accettati e valorizzati.
5 La fragilit? e immaturit? dei genitori.
In altri casi sono prevalenti le strutture caratteriali che rendono questi genitori deboli e fragili psicologicamente, tanto da non sopportare la propria o l’altrui sofferenza. Identificandosi nel figlio cercano di evitargli ogni pena per paura di infliggergli traumi e complessi psicologici. E come se lIo bambino che soffriva per le proibizioni dei genitori, avesse il sopravvento sulladulto responsabile che ha dei doveri ben precisi sul minore il quale dovrebbe sapere che anche la sofferenza fa parte del bagaglio umano e contribuisce alla formazione del carattere e della personalit?. In questi casi si crea un circolo vizioso: genitori immaturi o fragili daranno vita a figli pi? immaturi e fragili, i quali a loro volta rischiano di far peggiorare la situazione nelle generazioni successive.
6. La ridotta sensibilit? verso il male morale e sociale.
In altri genitori permissivi appare ridotto al lumicino o in alcuni casi scomparso il concetto di peccato e di male. Ogni atteggiamento viene ad essere capito, accettato e giustificato anche in nome di una modernit? e attualit? nei comportamenti. Pertanto essi accettano lo spinello, il turpiloquio e la sessualit? disinibita e totalmente libera da responsabilit? come segno di progresso e demancipazione da vecchi e antiquati tab?.
7. La maggiore ricchezza e benessere materiale.
La maggiore ricchezza ed il maggior benessere materiale inducono ad essere economicamente pi? liberali anche per far partecipare i figli delle maggiori entrate familiari ottenute spesso sacrificando il dialogo e la cura verso di loro. In pratica viaggi, regali, e contribuzioni economiche in cambio daffetto, dialogo, cure e attenzioni costanti e stabili.
8. I maggiori svaghi dei genitori.
La ricerca spasmotica e continua di divertimenti e la presenza datteggiamenti disinibiti e liberali che gli adulti si concedono nella vita sociale, sessuale e sentimentale, li spinge ad essere a loro volta liberali con i figli come per giustificare e sdrammatizzare i loro comportamenti evitando nel frattempo sensi di colpa e d’indegnit?.
9. La conflittualit? dei genitori.
Frequente causa del permissivismo ? la conflittualit? tra i i due sessi e tra i genitori che porta ad una situazione concorrenziale nei confronti dei figli.
E come se ognuno dei due genitori, che vivono una situazione di sfiducia e aggressivit? reciproca cercasse in tutti i modi di dimostrare ai figli di essere il genitore buono a lui alleato contro laltro quello cattivo, che non ama e non capisce. Come conseguenza vi ? la lotta per avere qualche spicciolo dattenzione e damore da parte dei figli sottraendolo allaltro genitore.
CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTO PERMISSIVO
Le conseguenze del permissivismo sul bambino e poi sul giovane e sulladulto sono note e descritte fin dallantichit? e riguardano vari settori del carattere e del comportamento.
La fragilit? di fronte alle frustrazioni
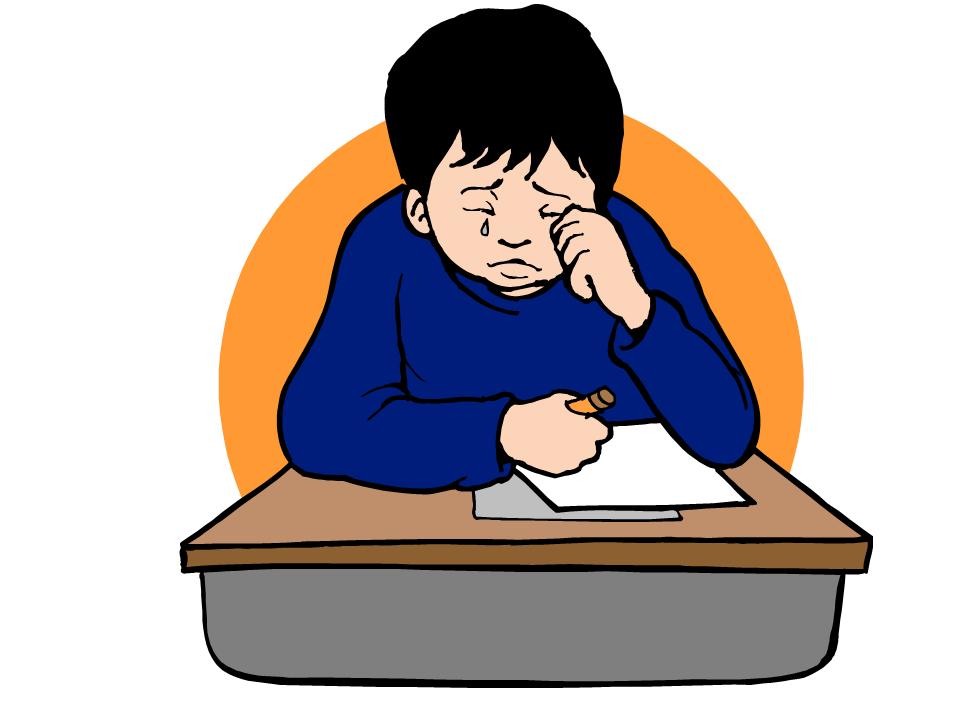
La fragilit? alle frustrazioni nasce inevitabile quando accanto a noi vi sono persone disposte sempre, o comunque spesso, a soddisfare ogni capriccio, ogni richiesta, ogni desiderio. In questi casi vi ? una visione distorta del mondo che viene considerato soltanto come occasione e fonte da cui trarre piacere, soddisfazione, accoglienza e non anche come luogo di confronto, di mediazione, di collaborazione, donazione e sacrificio. Inoltre, il trovare sempre qualcuno disposto ad accoglierci, accontentarci e perdonarci non d? quelle giuste sollecitazioni affinch? si fortifichino il carattere e la personalit?.
Tale fragilit? si manifesta nel bambino con pianto frequente e atteggiamento lagnoso per motivi anche banali. E questo un pianto che difficilmente si riesce a placare se non concedendo ci? che egli chiede, pur sapendo che si ripresenter? puntuale al prossimo diniego.
Nel giovane la fragilit? assume i contorni di un atteggiamento gregario nei confronti dei coetanei che dimostrano forza, arroganza, autorit?, con difficolt? a resistere alla loro influenza anche quando essi propongono atteggiamenti e comportamenti contrari alla morale e ai valori in cui si ? cresciuti e si crede.
Dipendenti dagli adulti, continuano a chiedere loro aiuto e assistenza, anche quando avrebbero let? e le capacit? per farne a meno. Fuggendo le responsabilit?, il comportamento infantile li spinge alla continua ricerca di piaceri banali. Avendo difficolt? a resistere alle frustrazioni e alle delusioni, immancabili nella vita, si rifugiano nella tossicodipendenza e nei casi pi? gravi nellautolesionismo e nel suicidio.
I disturbi del comportamento.
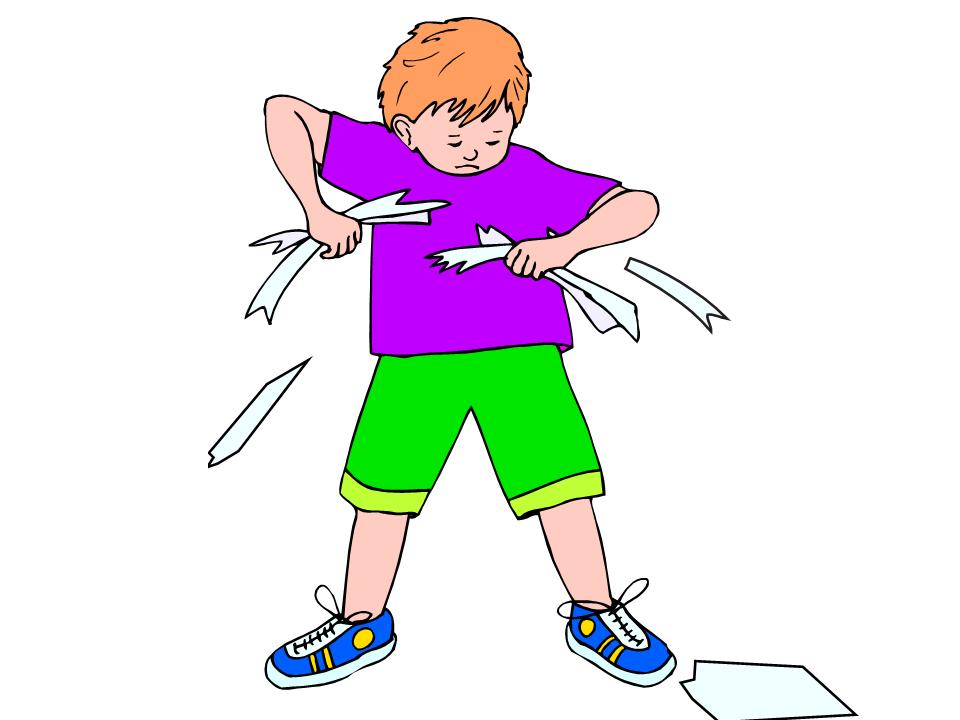
I disturbi del comportamento sono anchessi molto spesso presenti nella vita di questi soggetti i quali, non avendo imparato ad esercitare la propria libert?, a causa di una mancanza parziale o totale dautocontrollo, ed avendo una scarsa capacit? di valorizzare i bisogni degli altri e le loro necessit? e diritti, fin da piccoli manifestano comportamenti provocanti, irritanti, distruttivi, aggressivi.
Quando essi raggiungono let? adolescenziale o adulta diventano, pi? rilevanti i comportamenti asociali o chiaramente devianti. La mancanza di regole porta ad evasioni stupide o drammatiche, in quanto non riescono spesso ad effettuare neanche scelte utili per se stessi. Poich? la mancanza di disciplina ? vista come mancanza dattenzioni, cure e sollecitudini, ma anche come fragilit? e debolezza dei genitori, si evidenziano, verso questi ultimi, segni di scarsa stima, sfiducia, aggressivit?. Linconscio desiderio dautorit? li spinge a cercare nei capi delle bande, quellautorevolezza che manca nei loro genitori.
L scarsa autonomia.
Anche lautonomia personale e sociale risente degli atteggiamenti permissivi. I bambini e i ragazzi continuano a chiedere agli adulti prestazioni cui potrebbero far fronte autonomamente in quanto pienamente capaci, sia dal punto di vista motorio, che fisico ed intellettivo. I genitori e gli adulti tendono ad essere schiavizzati da questi piccoli tiranni che necessitano e pretendono le cose pi? disparate e semplici, che richiederebbero soltanto un minimo di fatica, impegno e sacrificio: il tenere in ordine la propria stanza o laiutare i genitori nelle mille occupazioni in casa e fuori, appare loro, come un immane impegno impossibile da affrontare, che ? quindi meglio far fare agli altri.
A volte gli adulti non vengono neppure ringraziati per quello che fanno e danno ogni giorno. Altre volte il ringraziamento si esprime in modo puramente formale e seduttivo, in quanto finalizzato ad ottenere in seguito pi? facilmente quanto richiesto.
Anche nelladolescenza e nella giovinezza, laiuto familiare ? minimo. Limpegno per lo studio sembra assorbirli completamente, perci? sentono questo e soltanto questo come lavoro ed occupazione. Tutto il resto, i mille quotidiani bisogni della famiglia e della societ? sono lasciati ai genitori e agli adulti. Per loro il tempo libero diventa solo divertimento. Si dedicano raramente a qualcosa di costruttivo per s? e per gli altri come la lettura di un libro, le attivit? sociali, laiuto e la collaborazione familiare. Il divertimento sembra la maggiore ricerca della nostra giovent?, i luoghi di divertimento sono diventate delle isole di piacere e stordimento morale
Nei riguardi del lavoro, poich? tali giovani non hanno mai imparato ad accettare la vita come dovere, collaborazione e sacrificio, limpegno ? molto scarso. Spesso lo rimandano con mille scuse, come rimandano in un futuro il pi? lontano possibile impegni importanti come il matrimonio, la maternit? e la paternit?.
Per questi giovani ? molto pi? comodo vivere uno o pi? rapporti amorosi liberi da impegni domestici in quanto la famiglia di origine ? un caldo e accogliente nido da abbandonare il pi? tardi possibile.
I sintomi di disagio interiore
Lavere tutto, lessere sempre accontentati da parte dei genitori, il vivere avvolti nella bambagia, piuttosto che dare felicit?, molto spesso produce sofferenza psicologica.
I doni, i molti regali ottenuti facilmente, gli oggetti di cui il giovane si circonda e dai quali ? circondato non gli danno il piacere della conquista n? autentiche soddisfazioni. Quando avvertono che il mondo esterno alla famiglia raramente ha atteggiamenti morbidi e accettanti come quelli con i quali sono abituati a convivere, capiscono a proprie spese che, nei confronti dei figli di mamma, i coetanei tendono ad essere pi? agguerriti e aggressivi, in quanto ne avvertono lintima debolezza.
Non protetti dal debole carattere, schiacciati dal proprio egoismo, non riuscendo ad aprirsi allamore vero e alla donazione di s?, crolla lautostima ed emergono la tristezza e lansia.
Poich? l’uomo ? fatto per l’azione, le conquiste e le difficolt? da affrontare sono le cose che danno pi? senso e sapore alla vita. Lavere tutto, subito e senza problemi, produce invece insoddisfazione, mancanza di equilibrio interiore, incoerenza, instabilit? emotiva.
Tratto dal libro di Emidio Tribulato “L’educazione negata Edizioni E.D.A.S.


No Comments